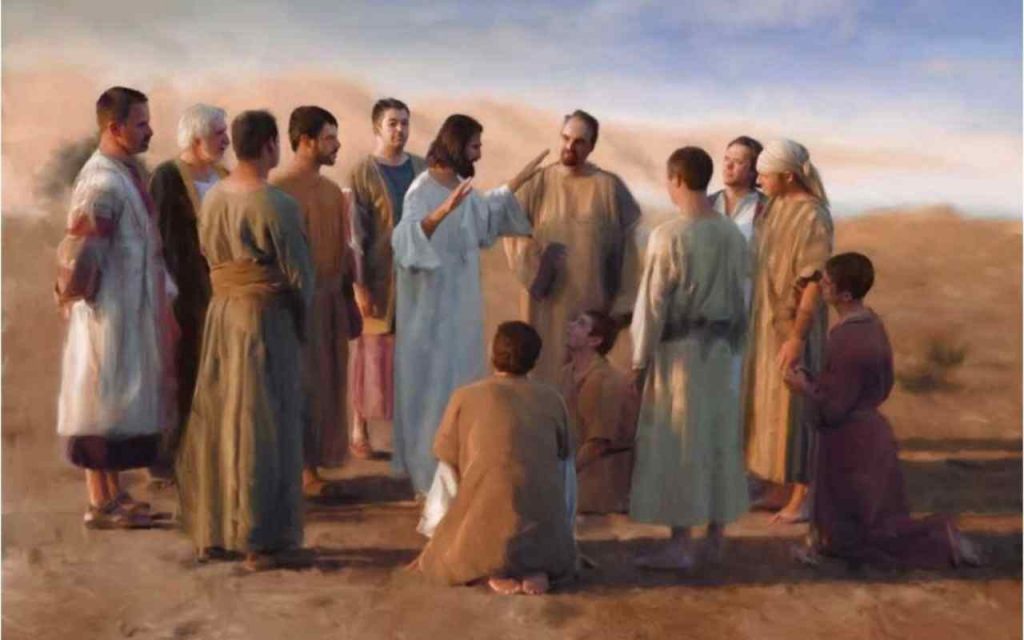
Is 6,1-2a.3-8
Altra bella pagina: vocazione di Isaia; anteriore cronologicamente a quella di Ger, di domenica scorsa. La scena si svolge nel tempio (v.5), al cospetto degli alati “serafini” (così il testo: da srf= essere bruciante; è detto anche per il serpente di bronzo di Num 21). Di per se gli esseri alati che coprivano l’arca a partire da Es 25 (ordini a Mosè) e 35 (esecuzione), ma si chiamano “cherubini”. Questi erano figure alate mostruose, scolpite alle porte delle città per difenderle dagli assalti del male e dai nemici. Secondo le disposizioni posteriori del documento sacerdotale (P), l’arca, coperta con le ali dai due cherubini, è nascosta, ma prima forse era visibile al profeta che pregava. Il canto dei serafini è messo dalla Chiesa all’inizio della preghiera eucaristica centrale: il “trisagion”. Uno dei serafini purifica le labbra per la difficile missione del profeta. I liturgisti che hanno scelto i brani hanno eliminato 6,2b, sulle sei ali del serafino: “con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava”. Anche il profeta Ezechiele, questa volta contemporaneo di P, nella sua vocazione (Ez 1) vede uno sfolgorio di ali di quegli esseri alati, che solo in Ez 10 vengono poi chiamati “cherubini”. Se ben ricordo, alla Verna nel dipinto della cappella, che descrive la visione in cui S. Francesco riceve le stigmate, c’è uno sfarfallio di ali attorno alle teste degli angioletti che lo circondano. Questa voglia di volare la esprimono bene le giovani danzatrici, alzando le braccia in punta di piedi; sfarfallio è un termine che evoca le farfalle, gli esseri che, proporzionatamente al corpo, hanno le ali più grandi. Questa voglia di volare rivela il desiderio umano di avvicinarci a Dio, ma ora che poremmo togliercela, con gli elicotteri, gli aerei e le astronavi, è scomparsa.
Sal 137
Nel quinto ed ultimo libro del salterio, finiti i salmi delle ascensioni, incontriamo un terzo gruppo di Salmi “di Davide” (il primo è costituito dai primi Salmi, una quarantina, a partire dal Sal 3; il secondo è quello dei Sal 51-70. Il Sal 71, visto domenica scorsa ne è l’appendice e parla di vecchiaia, anticipando proprio il 3° gruppo, iniziato appunto nel 138 (137). Questi ultimi salmi di Davide sono meno lamentosi di quelli dei gruppi precedenti e più sereni, nella speranza di qualche al-di-là, non ancora rivelato nell’AT. Forse la scelta del Sal 138 è determinata dalla speranza in qualche buon esito della missione della Chiesa, la quale è pure il tema della domenica.
1Cor 15,1-11.
Paolo inizia il lungo tema della risurrezione, di cui ci occuperemo per ben 4 domeniche, fino alla Quaresima. Ovvio che si cominci dalla risurrezione di Gesù, base della nostra. Perciò l’apostolo mette le basi rifacendosi ai fatti e alle testimonianze sulla risurrezione di Gesù, prima di tentare le sue spiegazioni sulla nostra.
Lc 5,1-11
Mescolata con il racconto della vocazione degli apostoli di Mt e Mc (Lc 5,10), la pesca miracolosa, ignota agli altri due sinottici, è una tradizione raccolta dalla propria attività redazionale, di cui Lc ci ha parlato all’inizio. Ma il racconto ricompare poi in Gv, ambientato nell’attività di Gesù risorto (Gv 21). Si direbbe che sia Lc ad ambientarla prima, perché egli, dopo la risurrezione non dà spazio all’attività del Risorto in Galilea. Con questa pagina la chiamata degli apostoli acquista così anche il valore d’una visione, oltre che di una vocazione. Visione della Gloria di Dio in Gesù, come quella di Is. della prima lettura. Così si spiega la reazione mistica di Pietro e degli altri (Lc 5,8s.). Lui, comunque, nel racconto di Gv è il protagonista. Lì la chiamata di Pietro è solo alla fine, dopo i rinnegamenti che Gesù vuol espiati, facendogli ribadire la sua scelta e confermandolo a capo dei dodici. Don Enzo Cortese
