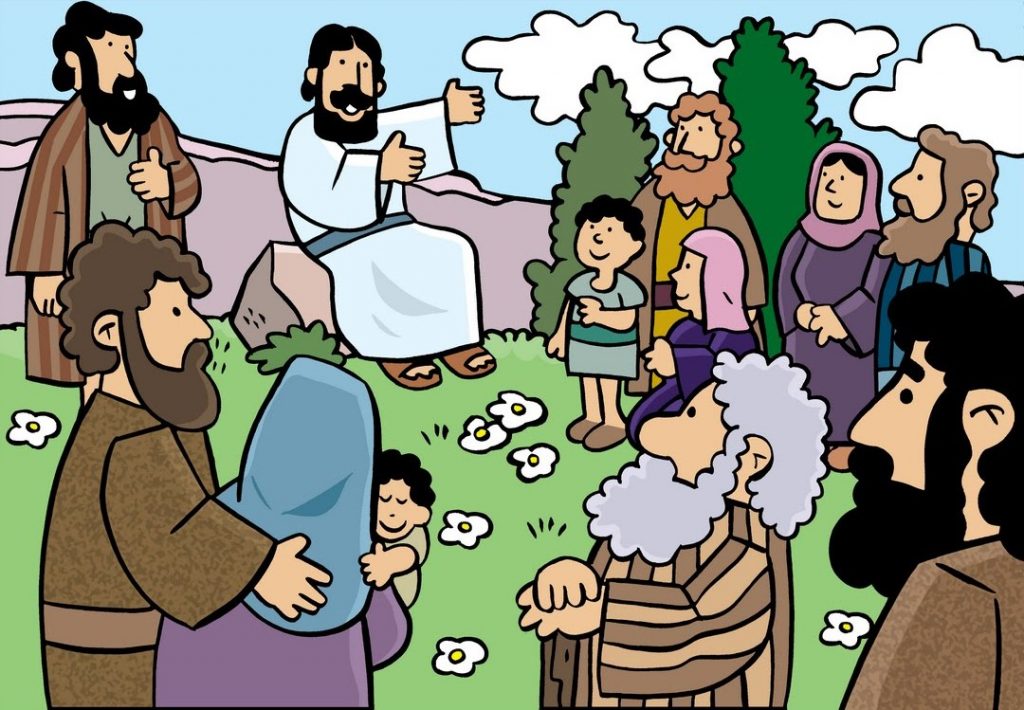
Domenica 7 T.O.
1 Sam 26,7-9.12-13.22-23
Siccome il tema dato dal vangelo è la misericordia e il perdono, si scelgono alcuni vv. qua e là di 1°Sam 26, che è uno dei due capitoli che raccontano come Davide, perseguitato da Saul, lo abbia risparmiato; l’altro racconto è al capitolo 24. L’episodio è soprattutto una mossa politica, opportunamente narrata e sfruttata per imbonire le tribù settentrionali, di cui faceva parte Saul. Davide regnò prima a Hebron, in Giuda, ma alla morte di Saul le tribù del Nord vennero loro a chiedere di far parte del suo regno (2Sam 5). Ma nei rapporti politici, nazionali ed internazionali, c’è sempre bisogno di saper perdonare, perché regni la pace. Lo dice spesso il Papa, specialmente nell’enciclica “Fratelli tutti”. Basta scorrerne l’indice, specialmente il cap.5 “La miglior politica”, dove si parla di “amore politico”, e il cap.7°, dove un paragrafo è titolato: “il valore e il significato del perdono”. Tutti siamo ora preoccupati per il conflitto tra l’Ucraina e la Russia. Si risolverebbe con la misericordia e l’amore politico.
Sal 103 (102)
Il salmo si trova verso la fine del 4° libro del salterio ed è piuttosto recente. Lo attestano nell’ebraico le frequenti forme tardive dei suffissi (nell’ italiano “di-gli”, “gli” è il suffisso). E’ una preghiera per celebrazioni dell’alleanza (il suo rinnovamento?): si veda il v.18. Vi si esalta la misericordia di Dio per noi. I vv. 8s. e 17s. evocano l’antico Es 34,6s, dove Dio stesso si proclama misericordioso. Come succede oggi, il salmo 103 tralascia ciò che in Es viene detto anche della Sua Giustizia: la punizione fino alla quarta generazione per i colpevoli. Una volta si voleva riempire l’inferno e adesso lo si vuole svuotare. Forse è meglio lasciare che faccia Dio! Però Gesù, massimo messaggero e artefice della misericordia, parla anche lui di geenna e di fuoco eterno (Lc 12,5). Da ricordare che anche l’Islam parte da Es 34: in tutte le Sure del Corano si inizia ricordando che Dio è “clemente e misericordioso”.
1 Cor 15,45-49
Come dice il “Catechismo della Chiesa Cattolica”, il modo della risurrezione resta un mistero (§ 1000). Il penultimo brano che leggiamo in 1Cor mostra che la contrapposizione “anima-corpo”, eredità della cultura greca, non va distrutta ma completata da quella di Paolo: “corpo naturale-corpo spirituale”. Dovremmo pure dedurne che Gesù prima della risurrezione era anche lui “corpo naturale”. Ma, come fa notare il citato catechismo (§ 994, con nota 565), manifesta già il suo potere nel ridare la vita ad alcuni, sempre con corpo naturale (la bimba di Giairo, il figlio della vedova di Naim e Lazzaro). Egli preannuncia tre volte nei Sinottici la sua risurrezione e parla spesso della nostra; ricordiamo il discorso sul pane di vita in Gv 6. Bisogna stare attenti a “non deviare dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta, sconvolgendo in tal modo la fede di certuni”, come fanno Imeneo e Fileto di 2Tim 2,15s.
Lc 6,27-38
Continua il discorso di domenica scorsa su beatitudini e guai, discorso parallelo a quello “della montagna” di Mt 5-7. Qui dovremmo chiamarlo “della pianura” (6,17). In effetti Lc lo ha posticipato, anticipandovi la chiamata dei dodici (6,12ss.) e iniziando il suo primo “inciso” (Lc 6,20-8,3), così lo chiamano gli specialisti (nei due incisi di Lc egli si discosta dall’ordine sinottico ed aggiunge qualcosa di suo). Mt mette invece il discorso appena chiamati i primi quattro, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. L’intento di Lc è mettere tutto il collegio apostolico completo come destinatario principale. In entrambi i vangeli la misericordia qui è un dovere nostro, per essere come il Padre (v.36). Ed è un dovere immenso. I cristiani hanno dovuto (?) amare i nemici fin dall’inizio, perseguitati dai Giudei che li cacciarono dalle sinagoghe, poi dai Romani, quando cominciarono a “dare nell’occhio” nell’impero, poi con i barbari. Amare i nemici divenne più difficile quando i Cristiani divennero potenti, nel sacro romano impero, poi al tempo dei Crociati, poi nei conflitti coi protestanti e all’epoca coloniale… Ora il Papa ci indica la strada della fratellanza con l’Islam e le altre religioni, specialmente là dove i nostri sono vittime e martiri. La partenza l’ha data Gesù, quando sulla croce morì dicendo “Padre perdona loro…”. Così ha manifestato l’amore e la misericordia di Dio. Come dovremmo fare anche noi, a partire dalle nostre famiglie, dalle comunità, dalle parrocchie, dalle diocesi.
